PUBE UOMO
CALCOLOSI URINARIA
La calcolosi, detta anche litiasi, è una delle più comuni e antiche malattie delle vie urinarie. Tale patologia è caratterizzata dalla presenza di piccoli sassolini, calcoli appunto, lungo il decorso delle vie urinarie. La formazione di calcoli è la conseguenza del medesimo processo chimico che comporta la precipitazione dello zucchero nella tazzina di caffè: se una sostanza contenuta nelle urine è più concentrata del normale, dando origine alla cosiddetta sovra-saturazione, rischia di precipitare e formare cristalli che fondendosi tra loro nel fondo dei calici renali formano appunto i calcoli, dal latino calculus (sassolino). Questo non avviene nei soggetti sani perché nelle urine ci sono delle sostanze che contrastano in maniera efficace la cristallizzazione, fondamentalmente citrati.
I calcoli renali possono essere costituiti da varie componenti chimiche, singole o in combinazione:
Nel mondo occidentale la maggior parte dei calcoli è costituita da ossalato di calcio, rappresentano il 90% dei casi e sono radiopachi;
Meno frequenti ma sempre radioopachi sono quelli di fosfato di calcio;
Quelli di acido urico, sempre più frequenti, sono radiotrasparenti, cioè invisibili nelle radiografie standard ma non alla ecografia, presentano la caratteristica favorevole di sciogliersi completamente solo alcalinizzando le urine con una terapia medica senza dover ricorre alla chirurgia;
Quelli di cistina, assai rari, spesso si manifestano fin dall’infanzia in pazienti portatori di una condizione patologica ereditaria definita cistinuria; spesso causano calcolosi complesse, voluminose, molto dure e difficili da trattare;
Capitolo a parte meritano i calcoli generati dalle infezioni delle vie urinarie (fosfati tripli), provocati da batteri che producono una matrice proteica che facilita la precipitazione dei sali disciolti nelle urine.
La calcolosi urinaria è una patologia molto diffusa nel mondo occidentale, e in Italia in particolare. Si calcola che colpisca circa il 10% della popolazione maschile e il 5% della popolazione femminile. L’età con maggiore incidenza è quella compresa tra i 30 e i 50 anni. Le recidive sono molto frequenti, tanto da verificarsi in una percentuale che varia, a seconda degli studi, dal 25 al 50% dei casi dopo 5 anni. L’incidenza stimata in Italia è di circa 100.000 nuovi casi all’anno. Tra le cause, viene data molta importanza alla familiarità, a una dieta squilibrata e alla scarsa assunzione di liquidi.
TUMORE ALLA PROSTATA
La prostata è una ghiandola – grande circa come una noce – che è presente solo negli uomini e che ha il compito di produrre e immagazzinare il liquido seminale.
Il tumore alla prostata è tra i più diffusi tra gli uomini, con un rischio è che strettamente legato all’età: con l’avanzare di questa aumentano i rischi, tanto che a 80 anni questa condizione riguarda 1 uomo su 2.
Le cause del tumore alla prostata non sono ancora state del tutto scoperte, ma è certo che alla base della malattia c’è una mutazione nel DNA delle cellule che provoca una proliferazione anomala delle stesse, il cui accumulo forma il tumore.
Il tumore alla prostata cresce in genere lentamente e non si diffonde al di fuori della ghiandola. Esistono però forme più aggressive, caratterizzate da cellule malate che invadono rapidamente i tessuti circostanti e si diffondono anche ad altri organi.
I fattori che possono aumentare il rischio di tumore alla prostata sono:
l’età: questo tumore si sviluppa maggiormente dopo i 65 anni;
le caratteristiche genetiche: gli uomini con la pelle scura risultano essere più a rischio degli altri;
la presenza in famiglia di altri casi;
l’obesità;
una dieta ricca di grassi saturi.
L’unica forma di prevenzione di questo tumore passa attraverso il contenimento del proprio peso corporeo. Obiettivo raggiungibile osservando una buona alimentazione, che limiti il consumo di grassi, soprattutto di quelli saturi (carni grasse di origine animale e formaggi).
Per quanto riguarda i sintomi del tumore al polmone, occorre sottolineare che agli stadi iniziali questa neoplasia in genere non ne presenta, tanto che il 30% circa dei casi vengono scoperti quando la malattia si è già diffusa oltre la ghiandola.
DIAGNOSI
Quali esami servono per la diagnosi e screening del tumore alla prostata?
Nella maggioranza dei casi, la diagnosi di tumore della prostata si affida agli esami di screening, spesso inseriti in una visita medica di routine, soprattutto negli uomini dopo i 50 anni di età.
Il medico può anche raccomandare esami specialistici a causa di sintomi indicativi di un disturbo alla prostata. Gli esami comprendono:
• Esame del PSA (Antigene Prostatico Specifico): è un prelievo di sangue con cui si verifica il livello ematico di PSA, una sostanza prodotta dalla ghiandola prostatica che serve a fluidificare il liquido seminale. Il PSA non è un marcatore tumore specifico, pertanto livelli elevati di PSA o livelli crescenti nel tempo possono indicare una prostatite, un’ipertrofia prostatica o un tumore della prostata.
• Esplorazione Rettale: il medico, dopo aver indossato un guanto lubrificato, introduce delicatamente un dito nel retto del paziente per palpare la parete posteriore della ghiandola prostatica premendo contro la parete dell’ano.
• Tomografia Assiale Computerizzata (TAC): per lo più in associazione con altri esami. Può mostrare i linfonodi patologici nella pelvi e nell’addome, dove il tumore prostatico tende a diffondersi. La TAC non fornisce, comunque, informazioni sufficientemente attendibili sullo stato della prostata o sullo stadio del tumore, e trova indicazione solo in casi selezionati.
• Biopsia: in presenza di un sospetto clinico (palpatorio) o biochimico (PSA elevato), il medico può raccomandare una biopsia prostatica multipla per via transrettale, in anestesia locale, mediante centratura ecografica.
L’esame consiste in un numero variabile di prelievi di piccoli campioni di tessuto da aree diverse della prostata. Il tessuto viene poi analizzato al microscopio per accertare la presenza di cellule neoplastiche. La biopsia è un esame generalmente ambulatoriale che non richiede il ricovero ospedaliero.
• Risonanza Magnetica Nucleare (RMN): viene utilizzata raramente e in casi specifici per valutare la presenza di malattia nell’osso e nelle parti molli.
• Scintigrafia ossea: procedura diagnostica utile per stabilire la diffusione del tumore alle ossa. La sua necessità dipende dal tipo e dallo stadio del tumore prostatico, oltre che dai valori di PSA.
TRATTAMENTI
Trattamenti per il tumore alla prostata
Gli approcci terapeutici per il cancro della prostata variano dalla vigile osservazione alla sorveglianza attiva, dalla radioterapia all’intervento di asportazione della prostata (prostatectomia radicale) all’ormonoterapia e alla chemioterapia.
La scelta del trattamento dipende da fattori come l’estensione del tumore, la sua eventuale diffusione extra-prostatica, l’età del paziente e il suo stato di salute generale.
Trattamento medico del tumore alla prostata In casi selezionati, per il tumore alla prostata la vigile osservazione – consistente nel monitoraggio del paziente con una valutazione periodica del PSA – e la sorveglianza attiva – cioè il monitoraggio del paziente con PSA e biopsie ripetute – possono rappresentare un’opzione.
In caso di tumore alla prostata avanzato può essere utile un’azione di ormonoterapia (da sola o insieme ad altre terapie) attraverso cui viene ridotta la produzione di ormoni sessuali, responsabili dell’accelerazione della crescita dello stesso tumore. Se il paziente sviluppa resistenza al trattamento ormonale può essere indicato un intervento chemioterapico.
Trattamento chirurgico del tumore alla prostata Si tratta del trattamento più diffuso per il tumore prostatico. La chirurgia come unica modalità terapeutica (senza quindi prevedere altri trattamenti successivi come radioterapia, chemioterapia, ecc.) è efficace per trattare il cancro circoscritto alla ghiandola prostatica.
Trattamento radioterapico del tumore alla prostata Le radiazioni possono essere utilizzate per trattare quasi tutti gli stadi del cancro della prostata, a seconda dello stato di salute del paziente e della gravità del tumore. La radioterapia viene utilizzata anche dopo l’intervento chirurgico nei casi localmente avanzati (radioterapia post-operatoria) per trattare l’area in cui era contenuta la prostata (loggia prostatica).
FAQ
L’ecografia alla prostata serve a diagnosticare il tumore alla prostata?
L’ecografia prostatica da sola non consente di fare la diagnosi di tumore della prostata. La diagnosi è sostanzialmente istologica mediante biopsia eseguita sotto guida ecografica trans rettale. Questa procedura viene eseguita in Day Hospital.
Il tumore alla prostata è un tumore che si può prevenire?
La diagnosi precoce di tumore della prostata è importante e si esegue mediante l’esame del PSA (antigene prostatico specifico), un esame del sangue, e una visita urologica annuale dopo i 50 anni.
Il tumore alla prostata è un tumore ereditario?
Il tumore prostatico non è ereditario. Tuttavia, è stata osservata familiarità. Pertanto i soggetti con parenti diretti (padre o fratelli) colpiti da tumore alla prostata dovrebbero sottoporsi ad attento monitoraggio
TUMORE DELLA VESCICA
Nella maggior parte dei casi, il tumore alla vescica – l’organo che ha il compito di raccogliere l’urina filtrata dai reni – ha inizio nelle cellule, dette transizionali, le cellule cioè che compongono il suo rivestimento interno. Le cause di questo tumore non sono del tutto chiare, esiste però una relazione e ad esempio il fumo, le infezioni urinarie da parassiti, l’esposizione alle radiazioni o a sostanze chimiche. Questa neoplasia si presenta quando alcune cellule della vescica smettono di funzionare in modo corretto e cominciano a crescere e a dividersi in modo del tutto incontrollato, arrivando a formare il tumore. Esistono diversi tipi di tumori alla vescica:
• il carcinoma a cellule di transizione, il più diffuso, che nasce nelle cellule che compongono il rivestimento interno dell’organo;
• il carcinoma squamoso primitivo, più raro, che colpisce le cellule squamose e sembra particolarmente legato alle infezioni da parassiti
• l’adenocarcinoma, molto raro, che ha inizio nelle cellule delle ghiandole presenti nella vescica.
Tra i fattori che possono contribuire ad aumentare il rischio di tumore alla vescica ci sono:
• l’età: si tratta di un tumore raro prima dei 40 anni
• la razza: la bianca è più colpita delle altre
• il sesso: gli uomini sono considerati più a rischio
• il fumo, a causa delle sostanze chimiche che si accumulano nell’urina dei fumatori
• la familiarità: presenza di casi di tumore alla vescica in famiglia.
Non esiste una specifica strategia di prevenzione del tumore della vescica, se non la non esposizione ai suddetti fattori di rischio.
DIAGNOSI
Come si può diagnosticare il tumore alla vescica?
La diagnosi precoce e accurata del tumore della vescica è essenziale per quanto riguarda quella che potrà essere l’efficacia del trattamento: può servire ad ampliare le opzioni terapeutiche a disposizione e quindi ad aumentare, in generale, le probabilità di guarigione.
In caso di un sospetto tumore vescicale, l’esame di prima istanza è l’ecografia dell’apparato urinario, esame non invasivo che serve ad accertare l’esistenza del tumore ma anche a monitorare possibili recidive. Un altro esame in grado di verificare l’esistenza di un tumore alla vescica è l’esame citologico delle urine, che permette di individuare la presenza di eventuali cellule tumorali di origine vescicale. Va tenuto presente che le citologie urinarie si eseguono su tre campioni di urina prelevata al mattino. Si tratta di un esame altamente specifico ma poco sensibile.
A seguire, nella scala temporale degli esami c’è la cistoscopia, che è una procedura minimamente invasiva, ambulatoriale e consiste nell’introduzione di uno strumento sottile e flessibile (il citoscopio) nell’uretra in anestesia locale, con il quale il medico ispeziona visivamente l’uretra e la vescica; l’uro-Tac e l’urografia-RM, che forniscono al medico un corredo di strumenti diagnostici utili a valutare lo stato del paziente; la PET, tomografia a emissione di positroni che, attraverso il deposito di un radio farmaco nelle lesioni neoplastiche ne permette l’individuazione.
TRATTAMENTI
Come si può curare il tumore alla vescica?
L’efficacia del trattamento del tumore della vescica è dato dalla somma di molti fattori, tra cui la tipologia e lo stadio evolutivo del tumore, oltre che l’età e lo stato di salute del paziente. Il trattamento è principalmente di tipo chirurgico che può essere integrato da un trattamento medico o radioterapico.
Trattamento chirurgico
Si tratta del trattamento primario per il tumore della vescica. In base ai bisogni clinici dei paziente, la chirurgia del cancro della vescica prevedere in prima istanza l’asportazione del tumore dalla parete vescicale per via endoscopica (TUR-V), la procedura può essere integrata da instillazioni endovescicali di farmaci. In un secondo tempo , in base anzitutto al dato istologico e al successo o meno dei trattamenti endoscopici si prende in considerazione l’asportazione dell’intera vescica (cistectomia radicale). I pazienti sottoposti a cistectomia radicale sono candidati all’intervento di ricostruzione della vescica quando possibile o ad una derivazione esterna mediante sacchetto.
Trattamento medico
In relazione al tipo di tumore, può essere necessario dopo la TURV effettuare cicli di instillazione endovescicale di chemio o immunoterapici.
Per i pazienti con tumore in stato avanzato, che si è diffuso in altre sedi oltre la vescica, il medico può suggerire la chemioterapia sistemica, anche come unica opzione terapeutica. In casi selezionati, può risultare appropriata anche una combinazione di radioterapia e chemioterapia adiuvante dopo cistectomia.
Trattamento radioterapico
La radioterapia può essere effettuata anche in associazione alla chemioterapia o in sostituzione della chirurgia nei soggetti affetti da carcinoma vescicale e non operabili per comorbidità.
FAQ
Quali sono i sintomi del tumore alla vescica?
I sintomi del tumore alla vescica simili a quelli di altre malattie che colpiscono l’apparato urinario. Si va dalle presenza di sangue nelle urine alla sensazione di bruciore alla vescica quando di preme sull’addome, dalla difficoltà a urinare alla facilità con cui si contraggono infezioni.
Chi è a maggior rischio di contrarre tumore alla vescica?
Corrono maggiori rischio i fumatori e coloro che seguono un’alimentazione troppo ricca di fritture e grassi. Alcune categorie professionali sono più esposte di altre, come quelle dei lavoratori dell’industria tessile, dei coloranti, della gomma e del cuoio, che espongono le persone a sostanze pericolose, come le amine aromatiche e nitrosamine.
Quanto è diffuso il tumore alla vescica?
Il tumore alla vescica rappresenta circa il 3 per cento di tutti i tumori e colpisce in particolare gli uomini (tre volte di più delle donne) di età compresa tra i 60 e i 70 anni.
TUMORE DEL TESTICOLO
I testicoli sono gli organi maschili preposti alla produzione degli spermatozoi e di alcuni ormoni. Il tumore del testicolo è una neoplasia rara, tuttavia è una delle più frequenti nei giovani. Il cancro si sviluppa in seguito a un’alterazione nelle cellule del testicolo, che provoca una crescita incontrollata delle stesse di determinando la formazione di una massa. La maggior parte dei tumori del testicolo originano dalle cellule germinali, che danno origine agli spermatozoi.
I principali fattori di rischio di questo tumore sono:
• il criptorchidismo, cioè la mancata discesa nello scroto del testicolo, che resta nell’addome o nell’inguine; il rischio rimane anche se il difetto è stato ridotto chirurgicamente
• lo sviluppo anormale del testicolo causato da malattie quali la sindrome di Klinefelter
• la familiarità, ossia la presenza di casi in famiglia di tumore al testicolo
• l’età: questa patologia colpisce soprattutto i giovani, in particolare tra i 15 e i 34 anni.
Per questo tipo di tumore non esiste un programma di prevenzione specifico e l’autopalpazione regolare dei testicoli rimane ancora oggi il metodo più efficace ed economico per intercettare una neoplasia testicolare in fase precoce.
Tuttavia pazienti con difficoltà riproduttiva associata a:
• ridotta conta spermatica
• testicoli con volume inferiore a 12 ml
• FSH elevato
• una storia clinica criptorchidismo
rappresentano una fascia di popolazione con un rischio più elevato di sviluppare un tumore del testicolo.
L’ecografia testicolare rappresenta un valido strumento diagnostico per restringere ulteriormente la selezione dei pazienti sub-fertili con un rischio di tumore particolarmente elevato. Nei pazienti con alterazioni del tessuto testicolare (microlitiasi-calcificazioni) è indicata, oltre alla autopalpazione, una ecografia testicolare con cadenza annuale.
DIAGNOSI
Per la diagnosi del tumore del testicolo si possono utilizzare:
• Esame obiettivo: lo specialista identifica eventuali alterazioni morfologiche del testicolo e richiede i necessari approfondimenti diagnostici.
• Ecocolordoppler e/o ecografia testicolare: è lo strumento più adatto per la diagnosi della lesione testicolare e per la valutazione della sua estensione locale. E’ una metodica non invasiva, senza alcuna controindicazione.
• Esami del sangue: l’innalzamento dei valori di alcune sostanze circolanti nel sangue (marcatori tumorali) può indicare la presenza di tumore del testicolo.
• Orchiectomia radicale inguinale: consiste nell’asportazione chirurgica di un testicolo (il tumore raramente colpisce entrambi i testicoli). E’ una procedura comunemente eseguita in tutti i casi di sospetto cancro del testicolo. Il tessuto asportato viene poi analizzato da un anatomopatologo allo scopo di accertare la presenza del tumore e le sue caratteristiche.
• TAC: è una metodica utile per definire l’esatta stadiazione della malattia (linfonodi retroperiotoneali e/o localizzazioni in altri organi o distretti corporei).
• PET (Tomografia a Emissione di Positroni): è una moderna tecnica diagnostica di ausilio nella ristadiazione dell’estensione della malattia.
TRATTAMENTI
A seconda del tipo di neoplasia e della sua estensione, sono possibili diverse strategie terapeutiche, tra cui vigile osservazione, chirurgia, chemioterapia, radioterapia.
Il paziente affetto da tumore del testicolo può avere problemi di fertilità.
Chirurgia
Se il tumore è diagnosticato in una fase precoce, l’intervento chirurgico di rimozione di un testicolo (orchiectomia radicale inguinale) può essere l’unico trattamento necessario, seguito da stretta osservazione. L’esame anatomopatologico per la determinazione del tipo istologico (seminoma, carcinoma embrionario, choriocarcinoma, tumore del sacco vitellino) del tumore riveste un’importanza cruciale per la definizione della terapia più adeguata.
L’asportazione di un testicolo desta spesso preoccupazione negli uomini. Oltre a produrre gli spermatozoi, il testicolo produce anche gli ormoni maschili: la funzione ormonale torna solitamente alla normalità dopo l’asportazione di un testicolo. Se necessario, il paziente può assumere ormoni allo scopo di ristabilire i livelli normali. L’asportazione di un testicolo non dovrebbe influire sulla funzione sessuale. In caso di preoccupazione per l’aspetto esteriore, gli urologi possono discutere con il paziente l’impianto di una protesi testicolare nello scroto.
In caso di diffusione del tumore oltre i testicoli, possono rendersi necessari un secondo intervento chirurgico, la chemioterapia o la radioterapia oppure una combinazione di queste terapie.
Qualora il cancro si sia diffuso ai linfonodi può essere necessario un intervento di dissezione dei linfonodi addominali (chirurgia retroperitoneale). L’asportazione dei linfonodi non influisce sulla capacità del paziente di avere un’erezione o un orgasmo. Tuttavia questo intervento chirurgico può diminuire la fertilità in quanto interferisce con l’eiaculazione.
Chemioterapia
Solitamente, il cancro del testicolo risponde molto bene alla chemioterapia. La necessità della chemioterapia dipende dal tipo, dallo stadio e dalle dimensioni del tumore. In seguito, può essere necessaria la chirurgia allo scopo di garantire la rimozione totale dell’eventuale residuo tumorale.
Alcuni farmaci antitumorali interferiscono con la produzione di spermatozoi: anche se molti uomini riacquistano la fertilità, talvolta l’effetto è permanente.
Radioterapia
La radioterapia è particolarmente efficace contro un tipo di cancro del testicolo detto seminoma. In genere, la radioterapia non influisce sulle capacità sessuali del paziente. Può tuttavia interferire con la produzione di spermatozoi: questo effetto è solitamente temporaneo e la maggioranza degli uomini riacquista la fertilità nell’arco di pochi mesi. Il paziente può comunque valutare l’ipotesi di ricorrere alla crioconservazione dello sperma prima di sottoporsi al trattamento.
VARICOCELE
Il varicocele è una delle più frequenti patologie a carico dell’apparato riproduttivo maschile. Si tratta in un rigonfiamento anomalo delle vene del testicolo.
Che cos’è il varicocele? L’anomala dilatazione delle vene del testicolo causa un reflusso patologico di sangue venoso dall’addome al testicolo. Ne conseguono ristagno di sangue, aumento della temperatura e scarsa ossigenazione dei tessuti. Il varicocele può provocare una diminuzione della produzione e della qualità del liquido seminale e può arrivare a causare infertilità. Insorge principalmente durante la pubertà, tra gli 11 e i 16 anni, e interessa nel 95% dei casi il testicolo sinistro.
Quali sono le cause del varicocele? Le cause all’origine del varicocele non sono ancora del tutto note. Si ritiene che un ruolo di primaria importanza alla base di questo disturbo sia giocato da una congenita debolezza delle pareti venose associata a incontinenza delle valvole che con il tempo – e soprattutto durante l’età puberale, quando i testicoli crescono più velocemente – possono causare la dilatazione delle vene.
DIAGNOSI
Quali sono i sintomi del varicocele?
Gran parte delle volte il varicocele è asintomatico ed è quindi necessaria una visita medica per diagnosticarlo.
In altri casi si possono avvertire diversi sintomi:
Dolore sordo al testicolo interessato.
Senso di pesantezza o fastidio a livello dello scroto (soprattutto dopo sforzi fisici, dopo una giornata trascorsa in piedi o dopo essere stati seduti per troppo tempo).
Quando il varicocele è di grado elevato le vene dilatate a livello del testicolo possono risultare palpabili e visibili
Il testicolo interessato può risultare più piccolo e in posizione più bassa rispetto all’altro.
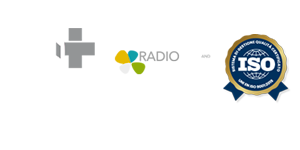
Unità Operativa di Marrelli Health S.r.l.
CASA DI CURA
Via G. da Fiore 5
88900 Crotone (KR)
tel. 0962 96 01 01
RADIOLOGY
&RADIOTHERAPY
Via dei Greci snc
(trav. via G. da Fiore)
88900 Crotone (KR)
Dir. Santitario
Dott. Massimiliano AMANTEA
C.F/P.IVA: 01356640795
REA: KR-111593
Capitale sociale Soc.
€ 2.706.235,00 i.v.
info@marrellihospital.it
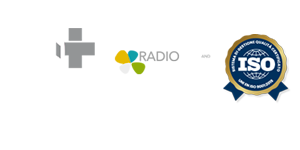
Unità Operativa di Marrelli Health S.r.l.
CASA DI CURA
Via G. da Fiore 5, 88900 Crotone (KR) – tel. 0962 96 01 01
RADIOLOGY&RADIOTHERAPY
Via dei Greci snc (trav. via G. da Fiore), 88900 Crotone (KR)

